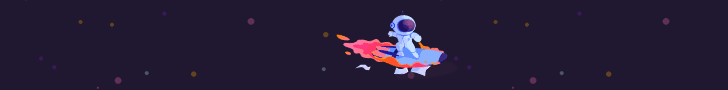Cultura di massa
La cultura di massa si riferisce tipicamente a quella cultura che emerge dai processi di produzione centralizzati dei mass media. Va notato, tuttavia, che lo status del termine è oggetto di continue sfide – come nell’identificazione di Swingewood (1977) come un mito. Quando è collegato alla nozione di società di massa, allora diventa una variante specifica di un tema più generale; vale a dire, la relazione tra i significati sociali e l’assegnazione delle opportunità di vita e delle risorse sociali. Considerata come un deposito di significato sociale, la cultura di massa fa parte di un gruppo di termini che include anche la cultura alta (o d’élite), la cultura d’avanguardia, la cultura popolare, la cultura popolare e (successivamente) la cultura postmoderna. L’interpretazione e i confini di ciascuna di queste categorie sono abitualmente oggetto di dibattito e controversia. Questo diventa particolarmente evidente nei tentativi di definizione ostensiva (cioè, la citazione di esempi di ogni termine e il ragionamento impiegato per giustificare la loro assegnazione alla categoria in questione). In combinazione, questi concetti costituiscono un sistema di differenze, tale che un cambiamento nel significato di uno qualsiasi dei suoi termini è spiegabile attraverso, e con, la sua mutevole relazione con gli altri. Quegli stessi termini funzionano frequentemente come categorie valutative che – tacitamente o esplicitamente – incorporano giudizi sulla qualità di ciò che si occupano di descrivere.
Nella sua introduzione a Mass Culture Revisited di Rosenberg e White (1971) Paul Lazarsfeld suggerì che negli Stati Uniti, la controversia e il dibattito rispetto alla cultura di massa erano fioriti più chiaramente tra il 1935 e il 1955. Era un periodo in cui il riconoscimento dei mass media come una forza culturale significativa nelle società democratiche coincideva con lo sviluppo di forme totalitarie di controllo, associate ai regimi e alle politiche mediatiche di Hitler e Stalin. Le affinità percepite tra questi sviluppi hanno spinto a preoccuparsi di come difendere al meglio le istituzioni della società civile, la cultura in generale e l’alta cultura in particolare dalle minacce che dovevano affrontare. Tali preoccupazioni contribuirono a plasmare il modello del dibattito sulla cultura di massa in quel periodo. Certamente, ciò che era evidente tra i commentatori sociali e i critici culturali americani era una diffusa antipatia verso la cultura di massa che raggiungeva le differenze tra i pensatori conservatori e quelli critici. Anche tra i difensori della cultura di massa, il tono giustificativo era caratteristicamente difensivo e apologetico (Jacobs 1964).
Per molti dei critici, una strategia tipica era definire negativamente la cultura di massa come “l’altro” della cultura alta (Huyssen 1986). Questa convergenza nel definire e comprendere la cultura di massa come tutto ciò che la cultura alta non è, è avvenuta in circostanze in cui la concezione di cultura alta che veniva valorizzata poteva essere (1) generalmente conservatrice e tradizionale, o (2) specificamente modernista e d’avanguardia. Per alcuni conservatori, in una linea di pensiero influenzata da Ortega Y Gasset e T. S. Eliot, ha preso la forma di una nostalgia sfacciata per un passato più aristocratico e presumibilmente più ordinato. Essi tendevano quindi a vedere la minaccia posta dalla cultura di massa come generata dal ”basso” (dalle ”masse” e dai loro gusti). Per i teorici critici come Theodor Adorno, la cultura di massa serviva interessi che derivavano dall’alto (i proprietari del capitale) ed era un’espressione dell’espansione sfruttatrice dei modi di razionalità che erano stati fino ad allora associati all’organizzazione industriale. La comprensione da parte di questo gruppo critico degli attributi di una cultura alto-modernista è che essa è – o piuttosto aspira ad essere – autonoma, sperimentale, conflittuale, altamente riflessiva rispetto ai media attraverso cui è prodotta, e il prodotto del genio individuale. La prospettiva corrispondente sulla cultura di massa è che è completamente mercificata, impiega codici estetici convenzionali e formali, è culturalmente e ideologicamente conformista, ed è prodotta collettivamente ma controllata centralmente in accordo con gli imperativi economici, le routine organizzative e i requisiti tecnologici dei suoi media di trasmissione. L’emergere di una tale cultura di massa – una cultura che è forzatamente fatta per il popolo piuttosto che fatta da esso – serve sia a chiudere la resistenza associata alla cultura popolare e all’arte popolare sia a quella serietà di intenti con cui si identifica l’alta cultura.
Il dibattito intorno a questa opposizione tra la cultura dell’alto modernismo e la cultura di massa fu, per la maggior parte, portato avanti dagli studiosi delle scienze umane. Ciò che si dimostrò essere un punto di contatto con gli scienziati sociali fu la relativa preoccupazione di questi ultimi sul fatto che lo sviluppo della modernità (intesa come processo sociale) fosse associato all’emergere della società di massa. Nella misura in cui la nozione di una tale società si fonda sul contrasto tra i pochi (organizzati) e i molti (disorganizzati), Giner (1976) suggerisce che la sua lunga preistoria nel pensiero sociale e politico risale alla Grecia classica. Allo stesso modo, Theodor Adorno ha visto la fondazione della cultura di massa come risalente al racconto di Omero, nell’Odissea, dell’incontro di Ulisse con le Sirene e il fascino seducente, ma profondamente insidioso, di queste ultime.
Una teoria specificamente sociologica della società di massa, tuttavia, con i suoi antecedenti negli scritti di Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, e Karl Mannheim, è del tutto più recente. Come formulata da scrittori come William Kornhauser e Arnold Rose, questa teoria era preoccupata di evidenziare tendenze sociali selezionate piuttosto che offrire una concezione totalizzante della società moderna. La teoria tuttavia avanza una serie di affermazioni sulle conseguenze sociali della modernità, affermazioni che sono tipicamente trasmesse per mezzo di un contrasto stilizzato con le presunte caratteristiche ordinate della società ”tradizionale” o, meno frequentemente, quelle forme di solidarietà, collettività e lotte organizzate che esemplificano la società ”di classe”. In breve, le relazioni sociali sono interpretate come trasformate dalla crescita e dallo spostamento nelle città, dagli sviluppi nei mezzi e nella velocità di trasporto, dalla meccanizzazione dei processi produttivi, dall’espansione della democrazia, dall’ascesa di forme burocratiche di organizzazione e dall’emergere dei mass media. Si sostiene che come conseguenza di tali cambiamenti c’è un declino dei legami primordiali di appartenenza al gruppo primario, parentela, comunità e località. In assenza di associazioni secondarie efficaci che potrebbero servire come agenzie di pluralismo e funzionare come tamponi tra i cittadini e il potere centralizzato, ciò che emerge sono individui insicuri e atomizzati. Essi sono visti come costituenti, in un’immagine influente del tempo, ciò che David Reisman e i suoi associati hanno chiamato “la folla solitaria”. La condotta ”rivolta all’altro” di tali individui non è né santificata dalla tradizione né il prodotto di una convinzione interiore, ma piuttosto è plasmata dai mass media e dalla moda sociale contemporanea.
Nella versione di C. Wright Mills (1956) della tesi il contrasto rilevante (e centrato sui media) non era tanto tra passato e pre-sentenza, quanto tra una possibilità immaginata e una tendenza sociale in accelerazione. La differenza più significativa era tra le caratteristiche di una ”massa” e quelle di un ”pubblico”, con questi due termini (di tipo ideale) distinti l’uno dall’altro dai loro modi di comunicazione dominanti. Un ”pubblico” è coerente con gli standard normativi della teoria democratica classica, in quanto (1) virtualmente tante persone esprimono opinioni quante ne ricevono; (2) le comunicazioni pubbliche sono così organizzate che c’è la possibilità di rispondere prontamente ed efficacemente a qualsiasi opinione espressa; (3) l’opinione così formata trova uno sbocco per un’azione efficace; e (4) le istituzioni autorevoli non penetrano nel pubblico, che è quindi più o meno autonomo. In una ”massa”, (1) molte meno persone esprimono opinioni di quante ne ricevano; (2) le comunicazioni sono così organizzate che è difficile rispondere rapidamente o efficacemente; (3) le autorità organizzano e controllano i canali attraverso i quali l’opinione può essere realizzata in azione; e (4) la massa non ha autonomia dalle istituzioni.
Come queste immagini implicano, e come Stuart Hall avrebbe successivamente suggerito, ciò che stava dietro il dibattito sulla cultura di massa era il soggetto (non così) nascosto delle ”masse”. Eppure questa era una categoria sociale della cui stessa esistenza Raymond Williams aveva notoriamente espresso dubbi, notando ironicamente che sembrava invariabilmente consistere di persone diverse da noi. Tale scetticismo era condiviso da Daniel Bell (1962), un pensatore altrimenti molto diverso da Williams. Nel criticare la nozione di America come società di massa, egli indicava i significati spesso contraddittori e le associazioni che si erano raccolte intorno alla parola “massa”. Potrebbe essere fatto per significare un pubblico eterogeneo e indifferenziato; o il giudizio degli incompetenti; o la società meccanizzata; o la società burocratizzata; o la folla – o qualsiasi combinazione di questi. Al termine veniva semplicemente chiesto di fare troppo lavoro esplicativo.
Inoltre, durante gli anni ’60, un tale svuotamento della base formale e cognitiva del concetto di cultura di massa fu sempre più integrato da sfide empiriche del tutto più dirette. L’emergere di una controcultura giovanile, il Movimento per i diritti civili, l’opposizione alla guerra del Vietnam, l’emergere del femminismo della seconda ondata, e le contraddizioni e le ambiguità del ruolo dei media nel documentare e contribuire a questi sviluppi, servirono tutti a mettere in discussione la tesi della società di massa. Inoltre, sia il controllo dell’industria della musica popolare da parte di una manciata di grandi compagnie (Peterson & Berger 1975) che quello della produzione cinematografica da parte dei grandi studios furono oggetto di serie sfide da parte di produttori culturali indipendenti con le loro priorità distintive (Biskind 1998). Il risultato (almeno per un decennio, fino all’eventuale riaffermazione del controllo aziendale) fu una cultura mediatica molto più diversificata. E in quella che forse era spiegabile come una reazione e una provocazione nei confronti di una precedente ortodossia, emersero anche casi di sostegno accademico in stile populista alla nozione stessa di cultura di massa – come, per esempio, nel Journal of Popular Culture. Se quest’ultima tendenza a volte mostrava un entusiasmo non riflessivo per l’effimero e una trascuratezza dell’analisi istituzionale, tuttavia presagiva il riconoscimento più ampio della diversità della cultura di massa che era evidente durante gli anni Settanta (per esempio, Gans 1974).
Negli anni Ottanta un’enfasi sulla ricezione culturale delle forme culturali popolari ha attratto un lavoro empirico innovativo (Radway 1984; Morley 1986) in un momento in cui la nozione di postmoderno era diventata oggetto di un’attenzione critica sostenuta. Il postmodernismo non mostrava nulla dell’antagonismo dell’alto modernismo verso la cultura di massa. Al contrario, man mano che si moltiplicavano le prove dell’offuscamento dei confini culturali, i praticanti dell’ismo postmoderno o interrogavano la base stessa di tali contrasti tra “alto” e “massa” e le distinzioni gerarchiche che li sostenevano (Huyssen 1986) o (in qualche modo) procedevano a ignorarli. Per esempio, il lavoro sulle soap opera televisive ha sovvertito la convenzione del disprezzo critico per tali testi dirigendo l’attenzione verso complessità strutturali come le linee di trama multiple, l’assenza di chiusura narrativa, la problematizzazione dei confini testuali e l’impegno del genere con le circostanze culturali del suo pubblico (Geraghty 1991).
Nelle sue forme ”classiche” la tesi cultura di massa/società di massa ha quindi perso molto del suo potere di persuasione. Permutazioni contemporanee delle sue affermazioni sono tuttavia distinguibili, per esempio, negli scritti postmarxisti di Guy Debord e Jean Baudrillard, e nell’affermazione dell’erudito critico conservatore George Steiner che è falso sostenere che è possibile avere sia qualità culturale che democrazia. Steiner insiste sulla necessità della scelta. Tuttavia, sono i perfezionamenti del concetto strettamente correlato di “industria culturale” che possono rivelarsi l’eredità più duratura e promettente della tesi (Hesmondhalgh 2002). L’industria culturale era stata identificata da Adorno e dal suo collega Max Horkheimer come un termine più accettabile di “cultura di massa”, sia perché metteva in primo piano il processo di mercificazione sia perché identificava il luogo della determinatezza nel potere aziendale piuttosto che nella popolazione nel suo complesso. Come originariamente concepito, presentava una concezione troppo cupa e totalizzante del controllo culturale. Un’enfasi sulla polisemia dei testi mediatici o sull’intraprendenza del pubblico dei media ha offerto un importante correttivo metodologico. Ma questi approcci potrebbero anche essere esagerati, e la globalizzazione della produzione dei media e una rinascita dell’analisi istituzionale e dell’economia politica tra gli studiosi dei media durante l’ultimo decennio hanno ravvivato l’interesse nel concetto di industria culturale.
- Bell, D. (1962) America as a Mass Society: Una critica. In: La fine dell’ideologia. Free Press, New York, pp. 21-38.
- Biskind, P. (1998) Easy Riders; Raging Bulls. Simon & Schuster, New York.
- Gans, H. (1974) Popular Culture and High Culture. Basic Books, New York.
- Geraghty, C. (1991) Women and Soap Opera. Polity Press, Cambridge.
- Giner, S. (1976) Mass Society. Martin Robertson, London.
- Hesmondhalgh, D. (2002) The Cultural Industries. Sage, London.
- Huyssen, A. (1986) After the Great Divide. Macmillan, London.
- Jacobs, N. (Ed.) (1964) Culture for the Millions? Beacon Press, Boston.
- Morley, D.(1986) Family Television. Comedia, London.
- Peterson, R. & Berger, D. G. (1975) Cycles in Symbol Production: Il caso della musica popolare. American Sociological Review 40(2): 158-73.
- Radway, J. (1984) Reading the Romance. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- Rosenberg, B. & White, D. M. (Eds.) (1971) Mass Culture Revisited. Van Nostrand, New York.
- Swingewood, A (1977) The Myth of Mass Culture. Macmillan, London.
- Wright Mills, C. (1956) The Power Elite. Oxford University Press, New York.
Back to Top
Back to Sociology of Culture.